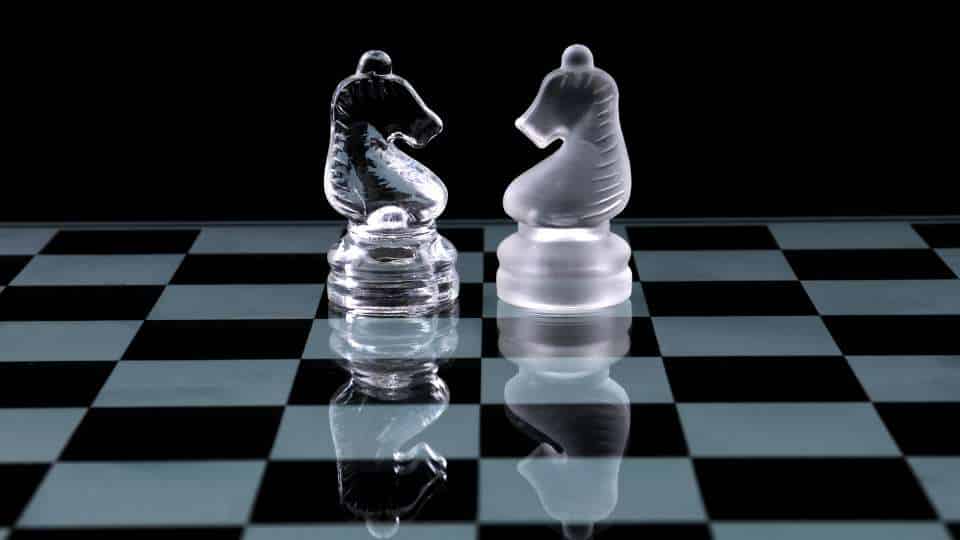Il caso della concorrenza parassitaria
Le aziende che operano sul mercato, qualunque sia il settore di riferimento, potrebbero trovarsi a dover affrontare la cosiddetta concorrenza parassitaria. Con questo termine si indica una pratica di concorrenza sleale per la quale un’impresa attua delle sistematiche operazioni con cui, letteralmente, copia prodotti, idee o iniziative dei concorrenti. Purtroppo, non sempre è facile e immediato individuare i casi di sistematica imitazione di iniziative o idee di imprenditori concorrenti.
Abbiamo dunque creato questa guida per analizzare in dettaglio la concorrenza parassitaria, fornire gli strumenti per riconoscerla e scoprire gli eventuali strumenti per difendersi.
La concorrenza parassitaria come illecito: una pratica di concorrenza sleale
Viene definita concorrenza parassitaria quella pratica di concorrenza sleale per la quale un imprenditore imita sistematicamente le idee dei competitor.
La conseguenza di questo tipo di illecito è quasi ovvia: emulare i concorrenti con iniziative del tutto identiche comporta una perdita di originalità. Causa dunque un danno anche alla concorrenza.
Si parla di questa condotta con sistematica imitazione di iniziative o idee di imprenditori concorrenti anche nel Codice Civile italiano. Sebbene, infatti, non esista una vera e propria definizione di concorrenza parassitaria nel nostro Codice Civile, ci sono diversi riferimenti chiari ai casi di concorrenza sleale. In dettaglio, l’Art. 2598 parla di concorrenza sleale ai commi 1 e 2. L’articolo in questione distingue due forme di concorrenza sleale, che può avvenire innanzitutto tramite azioni di confusione. In questo caso, si confondono le proprie attività e i propri prodotti con quelli dei concorrenti per trarne vantaggio.
La concorrenza scorretta comunque può avvenire anche denigrando i prodotti o le attività dei competitor, o con azioni di vanteria.
Cosa prevede l’articolo 2598 del codice civile comma 3 in merito alla sistematica imitazione di iniziative o idee di imprenditori concorrenti
L’articolo 2598 del Codice Civile, al comma 3, entra ancor più nel dettaglio, inserendo tra gli atti di concorrenza sleale anche quelli che non rispettano la correttezza professionale.
È ovvio che si tratta di una categoria molto ampia, ma possiamo inserire tra questi atti anche la concorrenza parassitaria.
Le origini della concorrenza parassitaria: la definizione del giurista Remo Franceschelli
Il primo a parlare della concorrenza parassitaria fu il giurista Remo Franceschelli, il quale la descrisse per la prima volta nel 1956. Franceschelli fece riferimento alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 per la sua prima teorizzazione.
Questa prima definizione indicò la concorrenza parassitaria come “la sistematica imitazione di iniziative o idee di imprenditori concorrenti”. Una imitazione che, come abbiamo già detto, causa una perdita di originalità.
Ricordiamo che, in effetti, se le idee non sono coperte da brevetto è possibile imitarle: in questo caso non si presenta illecito. Tuttavia, l’imitazione non deve avere carattere di sistematicità, altrimenti si verrà a configurare concorrenza parassitaria.
Quando copiare o emulare sistematicamente diventa concorrenza parassitaria
Perché si possa parlare di concorrenza parassitaria, è necessario individuare diversi elementi che non devono mai mancare. Innanzitutto, è necessario che si verifichi uno sfruttamento di idee (o anche iniziative) dei competitor.
Un secondo elemento che caratterizza questo tipo di concorrenza sleale riguarda l’eventuale originalità di idee e iniziative.
È necessario, poi, che l’imitazione sistematica comporti un effettivo danno ai competitor.
Caso Motta-Alemagna (sentenza n. 752 del 1962)
Abbiamo già detto che manca una vera e propria definizione di concorrenza parassitaria all’interno della legislazione italiana. Infatti, nel Codice Civile manca una definizione puntuale e che non sia vaga. Dunque, per individuare questo tipo di concorrenza si fa spesso riferimento alle pronunce fatte, negli anni, dalla Corte di Cassazione.
Una delle sentenze tra le più usate è quella relativa al celebre caso Motta-Alemagna (sentenza n. 752 del 1962). Questa sentenza permette di individuare una specifica tipologia di concorrenza sleale, la concorrenza parassitaria diacronica.
Negli Anni Sessanta, Alemagna accusò Motta di condotte illecite, caratterizzate da diverse imitazioni protratte nel tempo. Non si era verificata, quindi, una sola imitazione, ma più imitazioni delle iniziative imprenditoriali di Alemagna da parte di Motta.
Motta, ancor più in dettaglio, venne accusata di imitare i prodotti Alemagna non solo nel confezionamento, ma anche nelle iniziative pubblicitarie.
La ditta offesa chiese dunque la condanna per queste forme di concorrenza sleale. Il caso Motta-Alemagna venne risolto con la sentenza n. 752 del 1962 della Corte Suprema. La Cassazione concluse che, nonostante la confusione tra i prodotti e i brand non si fosse verificata, il comportamento di Motta era comunque sleale e contrario alla correttezza professionale.
Concorrenza parassitaria sincronica (sentenza n. 5852 del 1984)
Negli anni successivi, oltre a quella diacronica, è stata inoltre possibile individuare anche un altro tipo di concorrenza parassitaria.
Parliamo, cioè, della concorrenza parassitaria sincronica (sentenza n. 5852 del 1984). Anche in questo caso, si è arrivati a individuare questa tipologia di concorrenza sleale grazie all’intervento della Cassazione.
La corte suprema stabilì infatti che lo sfruttamento di idee e iniziative altrui non deve necessariamente essere reiterato. I comportamenti, anche se non protratti nel tempo e pur nel caso in cui si manifestino simultaneamente in un unico episodio, rappresentano comunque una forma di concorrenza scorretta.
Nella concorrenza parassitaria sincronica si supera dunque il concetto di ripetitività nel tempo, che non è necessario perché si possa parlare di questo illecito.
Come tutelarsi da chi cerca trarre vantaggio dalle iniziative e dalle idee degli altri operatori economici
Sulla base di quanto detto fino ad ora, viene spontaneo domandarsi come ci si può tutelare da chi prova a trarre vantaggio dalle iniziative e dalle idee degli altri operatori economici.
Ricordiamo che l’Art. 41 della Costituzione parla di libera concorrenza, ma questo non deve indurre in inganno. Esistono infatti dei limiti che tutelano le parti lese.
In caso di concorrenza parassitaria, quindi, esistono degli strumenti che permettono alle aziende di proteggere iniziative o idee.
Dopo aver raccolto le prove dell’illecito, è possibile inviare una diffida stragiudiziale tramite avvocato. In questo caso, si intima al concorrente di interrompere le attività di concorrenza illecita: di solito, basta questo per proteggersi.
In alternativa, è possibile rivolgersi al Tribunale per un procedimento d’urgenza o coinvolgere il competitor in una causa di merito.