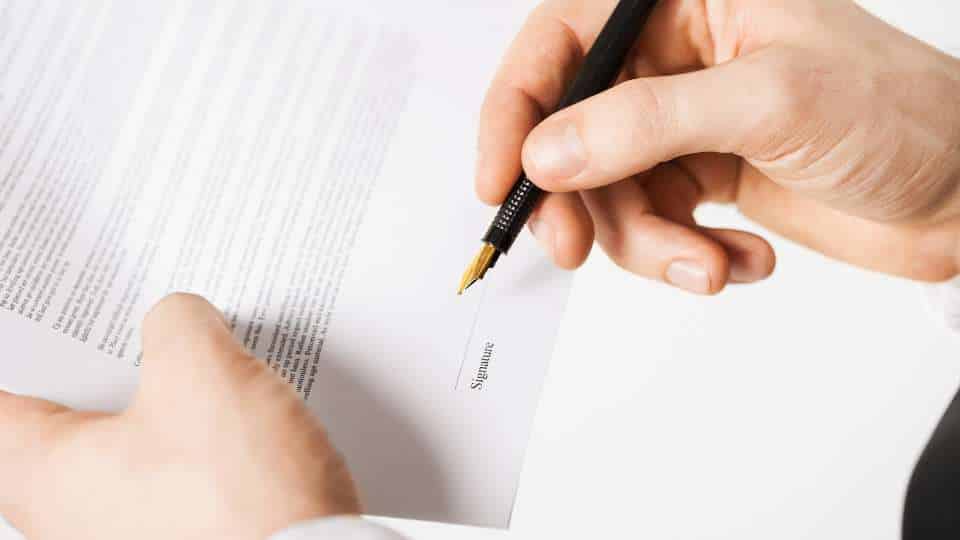Contratti aleatori spiegati in modo semplice
Quando il contenuto delle prestazioni che andranno rese ha natura incerta, è possibile sottoscrivere i contratti aleatori. Questa tipologia di contratto, tuttavia, può nascondere diverse incertezze. Sappiamo bene, innanzitutto, che per legge un contratto deve essere redatto rispettando alcuni requisiti. Possiamo indicare tali requisiti come elementi fondamentali, che sono chiaramente espressi nel Codice Civile.
All’interno dell’art. 1325 del Codice Civile, infatti, non solo viene fornita la definizione del contratto, come accorto tra parti. Viene anche stabilito che, anche se all’interno del documento non viene espresso chiaramente cosa comporta la sottoscrizione, il contratto può essere considerato valido. E questo è proprio ciò che avviene con i contratti aleatori.
Contratti aleatori: definizione e di cosa si tratta
Per comprendere al meglio la natura dei contratti aleatori bisogna conoscerne, innanzitutto, la definizione.
Come il termine stesso lascia intendere (dato che deriva da alea, ossia rischio), si tratta di tipologie contrattuali caratterizzate da incertezza.
Nel linguaggio giuridico, l’alea è proprio questa componente di rischio o incertezza che caratterizza l’accordo. Il contratto si basa sul fatto che l’equilibrio tra le prestazioni non è certo sin dall’inizio: può risultare vantaggioso o svantaggioso per una delle parti, a seconda di come andranno le cose.
Infatti, nel momento in cui sottoscrive il contratto, il firmatario non è certo che le prestazioni in oggetto verranno eseguite.
A differenza dei contratti tradizionali, dove entrambe le parti conoscono fin dall’inizio esattamente cosa otterranno, nei contratti aleatori c’è un elemento di incertezza.
Le prestazioni sono infatti strettamente legate al verificarsi di eventi futuri, che non dipendono dalle due parti. Se l’evento non si verificherà, la prestazione non verrà resa. Eppure, chi sottoscrive il contratto è comunque tenuto a pagare la polizza. Si parla quindi di rischio contrattuale, per indicare un elemento fondamentale, ma non certo, dal quale dipende l’effettivo svolgimento della prestazione.
Al momento della stipula dei contratti aleatori, le parti sanno bene che l’evento potrebbe non verificarsi mai. Eppure, entrambe le parti, con la firma, accettano questo dettaglio. In pratica, le parti accettano che il proprio guadagno o la propria perdita dipenderanno da un evento futuro e incerto.
L’obbligazione condizionata
Nei contratti aleatori, le obbligazioni assunte dalle parti non sono certe, ma condizionate. Ciò significa che l’obbligo di eseguire una prestazione nasce solo se si verifica uno specifico evento oggetto di contratto.
Si tratta di una caratteristica distintiva del contratto aleatorio: non è sufficiente che le parti firmino. Gli obblighi scattano solo se l’evento aleatorio si verifica.
Le tipologie più comuni
Anche se, leggendone la semplice descrizione, questa tipologia di contratto a prima vista può sembrare poco comune, in realtà nella vita quotidiana è molto diffusa.
Il tipico esempio di contratti aleatori è quello rappresentato dalle assicurazioni per le auto.
Di fatto, chi sottoscrive una polizza RC auto si impegna a pagare il premio assicurativo. Tuttavia, non è affatto detto che il sinistro per il quale ci si assicura avverrà sul serio.
Altra tipologia molto comune di contratti aleatori è rappresentata dalle scommesse sportive.
Anche in questo caso, chi scommette si impegna ad effettuare un pagamento. Eppure, la vittoria e il recupero di una somma maggiore rispetto a quella scommessa non è affatto garantito.
Differenza con il contratto commutativo
Spesso i contratti aleatori vengono citati insieme a quelli commutativi, perché si tratta di tipologie contrattuali tra loro contrapposte. Infatti, nel contratto commutativo le prestazioni sono chiare, determinate e di valore equivalente sin dalla firma.
Nel contratto aleatorio, invece, non c’è certezza né di ricevere né di dare una prestazione specifica, perché tutto dipende da eventi futuri.
Questa differenza influisce su come si valutano i contratti in sede legale. I contratti commutativi possono essere annullati se uno dei contraenti riceve una prestazione sproporzionata rispetto all’altra. Nei contratti aleatori, invece, l’alea giustifica l’apparente squilibrio.
La normativa sui contratti aleatori
Come abbiamo anticipato, dei contratti aleatori si parla nel Codice Civile. Tuttavia, non esiste una normativa specifica di riferimento: per la disciplina relativa a questo tipo di contratto bisogna quindi reperire i riferimenti all’interno del Codice Civile.
Il C. C., in realtà, fa più spesso riferimento alla cosiddetta vendita aleatoria. Gli articoli in cui se ne parla sono l’ex art. 1472 comma 2, l’ex art. 1998, gli art. 1448 e 1469. Inoltre, si parla dei contratti aleatori anche all’art. 1895 del Codice Civile. Si tratta di un articolo fondamentale perché si specifica che, per poter parlare di contratto aleatorio, è necessario che vi sia un rischio nella realizzazione della prestazione.
In sostanza, se l’evento futuro che darà origine è certo, non si può parlare di contratti aleatori. Per entrare ancor più nello specifico, l’Art. 1896 stabilisce che, una volta cessato il rischio, l’accordo si risolve automaticamente.
Un caso specifico: le assicurazioni
Abbiamo già inserito, tra le tipologie più comuni di contratti aleatori, quella delle assicurazioni.
Quando si sottoscrive un contratto del genere, chi decide di assicurarsi paga senza sapere se riceverà mai la prestazione. Il verificarsi dell’evento coperto con l’assicurazione, infatti, non è certo.
Questo tipo di contratto viene spesso citato tra gli esempi di contratto aleatorio perché presenta l’elemento tipico dell’incertezza. L’evento futuro non solo è incerto, ma non dipende assolutamente dalla volontà delle due parti che sottoscrivo il contratto.
Tuttavia, è bene sottolineare che, sebbene nel momento in cui l’evento non si verifica è l’assicurato a subire l’alea, nel momento in cui avvengono dei sinistri l’alea sarà subita dall’assicurazione.
Le polizze vita
Tra i contratti aleatori di tipo assicurativo, abbiamo anche le cosiddette polizze vita, che assicurano agli eredi di un defunto una determinata somma.
Anche in questo caso, l’elemento tipico del contratto è un evento futuro che non dipende da chi sottoscrive la polizza. Se, per esempio, a sottoscrivere la polizza vita è un giovane che, per disgrazia, muore poco dopo aver sottoscritto il contratto, l’assicurazione sarà costretta a pagare ai familiari le somme.
E qui scatta l’alea: infatti, in questo caso, anche se il giovane ha effettuato un solo versamento della polizza, al momento della sottoscrizione l’assicurazione si è impegnata a pagare le somme.
Dovrà quindi assolvere alle obbligazioni contrattuali che la sottoscrizione prevede, anche se il giovane non ha corrisposto ingenti somme data la prematura scomparsa.